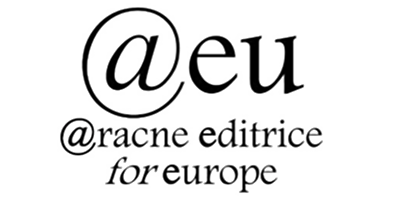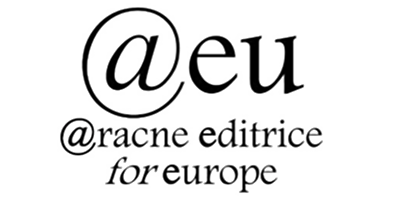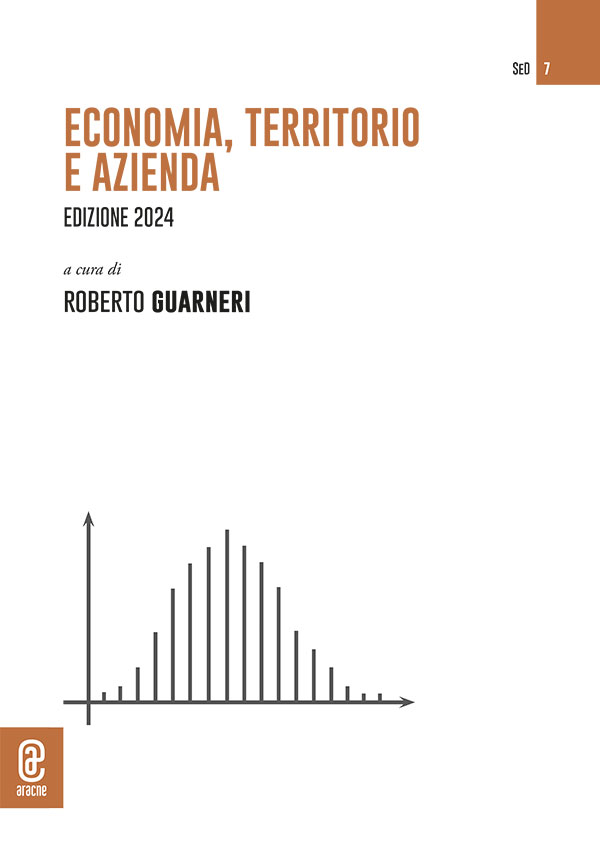Estratto dal volume Economia, territorio e azienda
Mood, sleep e lifestyle: cosa è cambiato nelle abitudini e nella percezione del proprio stato di salute dopo l’era Covid? Uno studio pilota osservazionale su un campione di studenti dell’Università degli Studi di Messina
DOI: 10.53136/97912218159932
Pagine: 13-36
Data di pubblicazione: Dicembre 2024
Editore: Aracne
SSD:
IUS/01 MAT/01 SECS-S/02 SECS-S/04 SECS-S/05
BackgroundGli ultimi anni sono stati caratterizzati da un’emergenza sanitaria inattesa legata alla pandemia da COVID-19, che ha inciso significativamente nella vita di studenti e giovani adulti. Ci si può chiedere se iproblemi rilevati a livello emozionale in coincidenza dello stato di pandemia stiano proseguendo negli anni successivi al COVID.Le modifiche riscontrate nello stato emotivo della popolazione riguardano lo stile di vita, le abitudini e, in particolare, le abitudini legate al sonno di giovani adulti impegnati in attività lavorative e di studio. Con riferimento a quest’ultimo punto, è ampiamente riconosciutocome l’acquisizione di schemi di sonno caratterizzati dall’andare a dormire tardi, alternati a giornate in cui i momenti di riposo non avvengono con regolarità, possa determinare un rendimento peggiore, sonnolenza diurna, stanchezza fisica, ed un aumento della probabilità diandare incontro a malattie psichiatriche.Molti studi di letteratura hanno investigato la correlazione tra sonnoe umore da un punto di vista clinico, evidenziando un’associazione positiva tra difficoltà legate al sonno e la presenza di sintomi psicologici.Tuttavia, si sa poco sulla percezione personale dei giovani riguardo alproprio stato psicologico.ObiettiviIl presente studio ha l’obiettivo di analizzare la correlazione tra variabilicome età, sesso, presenza di sintomi depressivi, ansia e abitudini legateal sonno in un campione di studenti universitari iscritti ai corsi di laureatriennali e magistrali in diversi Dipartimenti dell’Università di Messina.I dati utilizzati nel presente studio sono stati raccolti mediante lasomministrazione di una survey composta da questionari internazionalmente validati: EuroQol-5D e Visual Analogue Scale (VAS), BeckDepression Inventory (BDI), Hamilton Anxiety Rating Scale, PittsburghSleep Quality Index (PSQI). 110 studenti hanno completato la survey,somministrata nel corso dello svolgimento delle attività didattiche.MetodologiaÈ stata svolta, inizialmente, un’analisi descrittiva, che ha evidenziato correlazioni significative tra le diverse dimensioni investigate nello studio.Successivamente, è stata condotta un’analisi statistico-econometrica:è stata creata la variabile LOW VAS estrapolando, dalla Visual AnalogueScale, che riporta lo stato di salute percepito, i valori inferiori o uguali alprimo quartile del punteggio VAS (Q1 = 77,5). Tale variabile qualitativa,dicotomica, impiegata come variabile dipendente, giustifica l’applicazione di un modello di regressione logistica binaria, e può, quindi, intendersi come una proxy della percezione di malessere da parte dei rispondenti.Sono stati stimati, dapprima, dei modelli univariati e, successivamente, un modello multivariato, al fine di identificare significativi fattori predittivi indipendenti di low VAS.Principali risultatiI risultati dell’analisi descrittiva hanno evidenziato una correlazione positiva tra bassi livelli di VAS e alti punteggi di BDI e HAR. Punteggielevati riportati nei questionari BDI e HAR sono indicativi di uno stato di fragilità emotiva che potrà evolversi, con grande probabilità in problemi psicologici. La presenza di disordini nel sonno corrobora questaevidenza: la probabilità congiunta di sintomi affettivi e problemi legatiad uno schema di sonno/riposo insufficiente evidenzia un quadro clinico complesso, che si riscontra con maggior frequenza in quei soggettiche svolgono anche attività lavorativa (38,2% del totale, di cui il 9,52%riporta un elevato punteggio BDI) o che hanno maggiori responsabilitàin ambito familiare (l’85,32% dei respondents vive in famiglia e, tra questi, il 19,35% ha un elevato punteggio BDI).Dalla stima dei modelli univariati e multivariati di regressione logistica è emerso che bassi valori per la VAS sono attribuibili essenzialmente a 3 covariate: il punteggio del Beck Depression Inventory, il punteggio della Hamilton Anxiety Rating Scale e il punteggio dell’item n.7della PSQI, relativo alla difficoltà nello svolgimento delle attività sociali a causa di uno stato di sonnolenza.Nello specifico, dall’analisi univariata, si evidenzia che livelli più elevati di depressione (OR = 1,187, p<0,001), punteggi più elevati dellaHamilton Scale (OR = 1,162, p< 0,001) e della variabile PSQI_7 (OR:1,135, p=0,003) incidono significativamente sulla probabilità di riportare bassi punteggi (score<=77.5) per la VAS, che può quindi intendersicome una proxy della percezione di malessere da parte dei rispondenti.Nella regressione multivariata i coefficienti stimati e il livello di significatività sono pari, rispettivamente a: OR = 0,189; p = 0,001 (BDI),OR = 0,183; p = 0,012 (Hamilton) e OR = 1,131; p = 0,003 (PSQI_7).Dallo studio emergono chiare implicazioni di carattere sanitario: lostato di malessere, segnalato da un basso punteggio nella VAS, può essere corretto ripensando il proprio stile di vita in modo consapevole. Ilriconoscimento precoce della presenza di sintomi affettivi in un campione di giovani adulti o di cattive abitudini legate, in particolare, alsonno, può risolversi agendo sulle motivazioni personali così da migliorare, al contempo, le performances lavorative e scolastiche.Una indicazione per i responsabili delle politiche educative e sanitarie,quindi, va nella direzione della predisposizione di programmi di counselling diretti agli studenti, già prima di intraprendere corsi universitari.