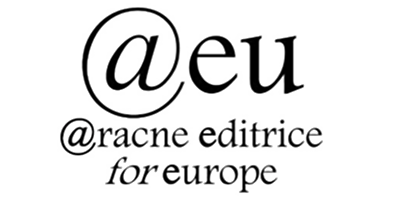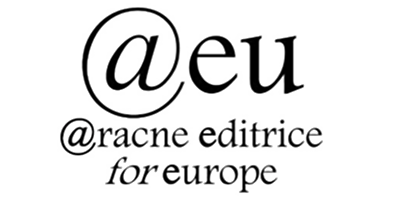13 febbraio 2025 |
Rivista Malamente |
Redazione
Recensione a Alessandro Paolo, Peregrinazioni non-violente per un ritorno all’Evidente. L’attualità degli insegnamenti gandhiani di Lanza del Vasto e dell’Arca.
Giuseppe Giovanni Lanza del Vasto è stato uno dei massimi maestri occidentali della non-violenzad’ispirazione gandhiana nel corso del Novecento. Il libro di Alessandro Paolo, Peregrinazioni nonviolente per un ritorno all’Evidente, ci avvicina a questa avvincente e originale figura del secoloscorso, al suo orizzonte di non-violenza radicale, alla sua spiritualità nel mondo e contro il mondo, ealle sue severe e scomode critiche «alle categorie di Stato e nazione, al capitalismo e al socialismo,alla società urbana, consumistica e tecnocratica, al colonialismo, al militarismo, al materialismo ateo,al fanatismo religioso, allo scientismo, al legalismo, all’assistenzialismo».
Si tratta di un ponderoso saggio in due volumi, dal taglio accademico ma che non è scritto perl’accademia; non è una distaccata trattazione di un oggetto di studio, quanto un appassionato viaggiolungo la Via della non-violenza, dove il percorso interiore dell’autore e la critica sociale dell’esistenteviaggiano all’unisono offrendoci profonde riflessioni filosofiche, storiche, giuridiche, etiche. La nonviolenza, infatti, parte dall’individuo che intende non nuocere ad alcun essere vivente, ma indicaanche la ricerca di un paradigma sociale che ripudi ogni forma di sopraffazione e, pertanto, riduca aun livello realmente sostenibile la predazione delle risorse del pianeta, cessi lo sfruttamento animale,superi lo Stato-nazione a favore di comunità locali, metodo assembleare, autonomia e responsabilità.L’autore, dunque, che ha profondamente interiorizzato gli insegnamenti della sapienza vedica e lascienza dello Yoga, nutrito anche da esperienze concrete e dall’attivismo per un programma politicocomunitario social-libertario, una visione biocentrica, una prospettiva di ristrutturazione individualee collettiva in senso decoloniale, si interroga sulla santità dell’individuo come essere spirituale, e altempo stesso, non dimentica la necessaria critica sociale per l’edificazione di una società migliore.Colpisce la sua apertura intellettuale capace di distaccarsi dalla matrice culturale e di potere colonialeper attingere alle fonti della consapevolezza – ovvero alle cosmovisioni e antropovisioni – maturatead altre latitudini rispetto alla modernità occidentale. E, qui, trovare i fondamenti dell’etica nonviolenta, tanto a livello teorico che pratico. Così come aveva fatto Lanza del Vasto.
La prima parte dell’opera ripercorre minuziosamente la biografia di Lanza del Vasto (1901-1981), perun buon tratto al fianco della compagna e sodale Chanterelle. Biografia che rivela un’esperienza ditrasformazione interiore e una vera e propria conversione con il primo viaggio in India nel 1936 el’incontro con Gandhi. Immerso nell’ashram del maestro, attingendo a piene mani alla dottrina e allaprassi non-violenta che avrebbero segnato la sua vita per sempre, riceve dallo stesso Gandhi il nomedi Shantidas (Servitore di pace).
Da lì in poi, del Vasto cercherà di divulgare e soprattutto adattare quanto aveva appreso al contesto“occidentale”, in particolare con la fondazione della comunità rurale dell’Arca, un esperimentocomunitario che si ramifica in Francia, Spagna, Italia e altrove, una rete di tribù votate a una «nonviolenza radicale e integrale, vegetariana, yogico-ecumenica, social-libertaria, decoloniale edecologista di laboriosità artistica, artigianale, agricola e semplicità volontaria». Una sorta di via dimezzo tra una comune naturista anarchica di fine Ottocento e un moderno ecovillaggio, che però nonsi chiude in se stessa ma guarda al mondo: «il lavoro manuale è di regola per tutti; non ci sono benipersonali; la comunità stessa deve possedere il meno possibile; le decisioni sono prese all’unanimità;esse tendono all’indipendenza per quanto riguarda i bisogni essenziali. [Queste comunità] facilitanosoprattutto le azioni non-violente nel lungo termine, poiché perdita di impiego, privazione dei diritticivili, prigione e altri rischi connessi all’azione perdono del tutto o in parte la loro forza dissuasivaper coloro che vivono in comunità indipendenti».
Il movimento che trae ispirazione dal maestro Shantidas non è, infatti, solo ruralismo ed estraniazione,bensì azione non-violenta. Come scrive l’autore, che per alcuni mesi ha conosciuto dall’interno,vivendoci, un paio di comunità: «I membri dell’Arca non hanno mai vissuto trincerati nelle lororoccaforti, rinchiusi nella loro felicità personale, noncuranti delle lotte del mondo: campagne, azionie iniziative non-violente da essi organizzate e realizzate rappresentano, piuttosto, pietre miliari nellastoria della non-violenza in Occidente, meritevoli di considerazione da parte di tutti coloro che siimpegnano in lotte per giustizia, libertà e pace autentiche».
Nell’aprile 1958, ad esempio, la comunità di Del Vasto partecipa all’occupazione della centralenucleare di Marcoule e, successivamente, è protagonista di un gran numero di digiuni, presidi e marcedi protesta: contro la minaccia atomica, per il disarmo e l’antimilitarismo, a sostegno delle comunitàcontadine e dei marginali. La non violenza è praticata come “terza via” gandhiana, strada intermediatra il mero impegno intellettuale e il ricorso alla violenza. Ancora negli anni Settanta ritroviamo DelLanza e i suoi alla testa della lotta non-violenta contro la centrale nucleare Superphénix, nei pressi diLione, quando cinquemila giovani da varie parti d’Europa tagliano le reti di recinzione e invadonopacificamente il sito, ricevendo manganellate, gas lacrimogeni e granate, mentre il maestro portavaavanti con altri attivisti una settimana di sciopero della fame. E intanto proseguono vorticosi i viaggiin giro per il mondo a tenere conferenze, tessere reti, costruire possibilità.
La morte del fondatore non passa senza profondi scossoni per la comunità che però, ancora lungotutti gli anni Ottanta, cresce e matura per poi confrontarsi con un inevitabile periodo di transizione erinnovamento: dagli anni Novanta alcuni gruppi si sciolgono, e i membri rimasti intraprendono unprocesso di riflessione sul senso della vocazione comunitaria. Il resto è storia recente, non certoconclusa; anche negli ultimi decenni la comunità dell’Arca ha co-organizzato innumerevoli campagnee azioni non-violente, ad esempio contro l’agricoltura intensiva e gli OGM, la vendita di armi, ilsettore nucleare ecc.
Un aspetto importante dell’organizzazione comunitaria, su cui il giudizio dell’autore è chiaro,riguarda l’accusa spesso rivolta dai detrattori, ovvero che a una fiera e distaccata autonomia neiconfronti delle istituzioni statali facesse da contraltare «un’organizzazione interna gerarchica eaccentrata in un Patriarca-Pellegrino considerato quasi come un re». «Dopo tre anni di ricerche,letture e riflessioni dedicate a risolvere anche questo enigma – scrive Alessandro Paolo – sento diaffermare, sulla base delle fonti reperite, che le supposizioni sia di una sua direzione autoritaria dellatribù, sia di un rischio totalitario in seno all’Arca, appaiono del tutto infondate».
La seconda parte del libro accompagna il lettore lungo un’articolata disamina delle tematiche care alpensiero di Del Vasto, espresse in primis nella sua vita e nel suo insegnamento quotidiano, ma anchenei suoi numerosi libri e scritti di vario genere. Temi vasti e profondi – l’ecologia, il dialogointerreligioso, il recupero delle antiche saggezze, la cura della spiritualità, tra gli altri – affrontati contratti piacevolmente spiazzanti per chi affonda le proprie radici nella cultura materialista che haegemonizzato i movimenti sociali dell’occidente moderno. E se il pensiero di Del Vasto è stato spessoe volentieri egemonizzato dal mondo cattolico, nulla toglie al suo potenziale di sovversionedell’ordine sociale, culturale, pedagogico e politico stabilito.
Il libro di Alessandro Paolo passa poi in rassegna il dibattito interdisciplinare contemporaneo suiconcetti di violenza, conflitto, autorità, disobbedienza, potere. Lo fa a partire dalle antiche radici dellanon-violenza (Ahiṃsā) rintracciate con grande competenza nella filosofia indiana, fino alle lotte didisobbedienza e resistenza civile del Satyagraha gandhiano (che qualcuno tra noi ricorderà legato airadicali del circense Marco Pannella). Soprattutto, crediamo sia utile approfondire il tema dell’azionepolitica non-violenta visto e considerato che sembra essere uno dei leit-motiv attorno ai quali ruota –a ragione o a torto, ognuno trarrà le sue conclusioni – l’attuale attivismo ecologista delle nuovegenerazioni.
Un ulteriore capitolo di sicuro interesse attiene al possibile contributo degli insegnamenti di Lanzadel Vasto e, in generale, dell’Arca, agli studi di educazione interculturale. Parole, oggi, tanto di modaquanto abusate, fatte proprie da istituzioni autoritarie e coercitive che le neutralizzano nelle vesti di“global education”, “cittadinanza attiva”, “educazione alla pace”, portatrici – queste istituzioni e leloro parole – di una concezione che «resta agganciata alle categorie epistemologiche, prima ancorache pedagogiche, sociologiche e politiche, della matrice moderno-coloniale di potere, fallendomiseramente nel proposito di generare un’autentica pluralità di sistemi di senso».
Di tutt’altra genuinità sono le esperienze di educazione alla non-violenza condotte all’interno dellecomunità dell’Arca, nutrite dalle migliori suggestioni pedagogiche alla libertà, da Don Milani a MariaMontessori, da Célestin Freinet a Rudolph Steiner, solo per citarne alcuni. La visione pedagogica difondo porta alla luce aspetti in piena assonanza con le pratiche delle attuali scuole e scuoline libertariedove si coltiva, in primo luogo, l’autonomia di bambini e bambine. Come racconta una testimone:«La nostra curiosità risvegliata era il motivo centrale del nostro successo. […] L’apprendimentodiventava un piacere». E ancora: «quando eravamo al liceo di Bedarieux, i nostri professori giunseroun giorno in visita, curiosi di scoprire la comunità dove vivevamo. Uno di loro dichiarò, andando via,che la principale differenza che aveva percepito a contatto con i bambini dell’Arca era che “essi nonsopportano l’ingiustizia e trattano da pari a pari, il che può essere colto come una forma di insolenza”.In effetti, […] avevamo l’abitudine di essere rispettati, ascoltati, presi sul serio». Non è forse un casoche una delle fonti principali utilizzate per questo capitolo l’autore l’abbia trovata, in originale, pressol’archivio del Centro internazionale di ricerche sull’anarchismo di Marsiglia.
Inoltre, un’ampia parte della trattazione è dedicata al pensiero decoloniale, ne consigliamo la letturaa chi vuol guardare il mondo con occhi diversi, ma non possiamo soffermarci in questanecessariamente breve – o quasi – recensione.
Restano invece alcune cose da dire su un altro tema centrale: il rapporto tra non-violenza e pensieroanarchico (e diritto), tema che si collega alla questione della coerenza tra mezzi e fini, che dovrebbeessere un punto fermo per chi intende costruire un mondo migliore. La suggestiva ipotesi dell’autoreè che «nella non-violenza si compie il passaggio da una situazione di monarchia esteriore e anarchiainteriore, terreno fertile per l’emersione e l’instaurazione dello stato moderno-coloniale (sia essorepubblica o regno, a regime dittatoriale, liberale o social-democratico), ad uno scenario in cui lamonarchia interiore del sé, dell’ātman, sovrano assoluto su fisiologia, emozioni, sentimenti e pensieriindividuali, si accompagna all’anarchia esteriore di piccole comunità armoniose, sobrie edautogovernate». Certo, l’anarchismo non-violento, così bene inquadrato in questo saggio, è purabellezza ma d’altra parte, come non trovare altrettanto affascinanti figure come Émile Henry, AugusteVaillant o Ravachol e tanti altri anarchici della propaganda col fatto che avevano un’idea ben diversadi come rispondere alla violenza della società?
Per quanto riguarda lo specifico di Lanza Del Vasto, sarebbe un’inaccettabile forzatura – «non solovelleitario, ma profondamente falso» – annoverarlo tra le figure del movimento anarchico. Di più, lastessa “rivoluzione” è per lui un inconcludente «giro di ruota», come suggerisce il termine stesso.Tuttavia Shantidas è stato un difensore della dimensione umana, un lucido e pungente criticodell’ideologia del progresso e della tecnica assurta a sistema totalizzante, ovvero dei pilastri su cui siregge l’attuale società, e tanto basta a farne, per noi, un pensatore più acuto e radicale di tanti sinistricompagni tecnocratici.
Per concludere con le parole di Giuseppe Aiello che ha firmato la postfazione, crediamo che questotrattato costituisca, per molti di noi, un’occasione di sfida a presunte certezze: «una verifica dellapossibilità di dialogare con un corpus di idee che si radica nella religiosità, in una verità che si trova(anche) oltre il percepibile e che mira alla libertà e alla pace come realizzazione umana e divina altempo stesso».